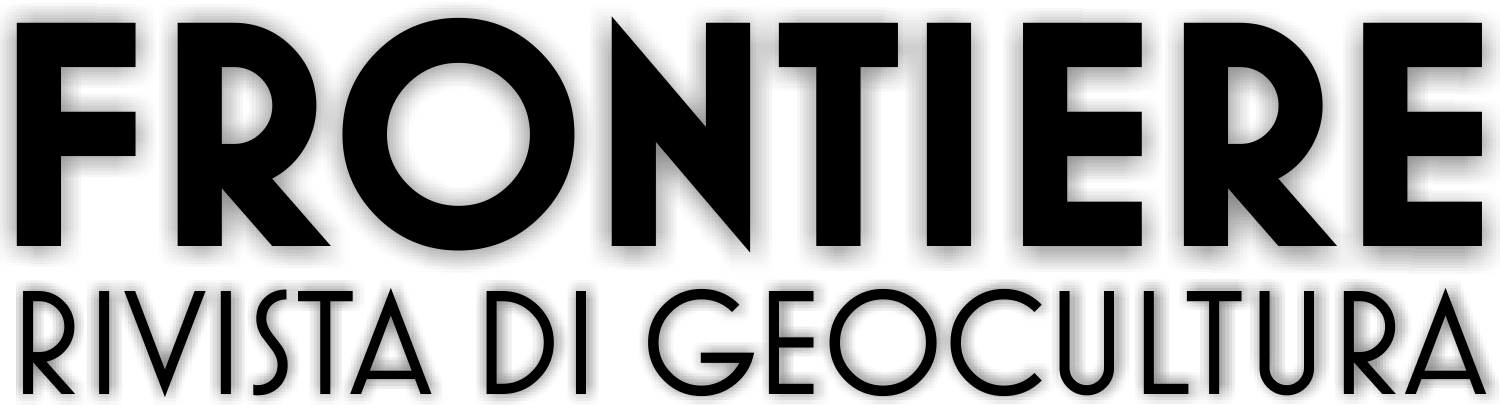“Tutti, criticando Israele, dicono ciò che non avrebbero fatto. Ma io vi chiedo cosa avreste fatto se foste stati voi al potere?”. Questa è la terribile domanda che il 31 ottobre scorso ha posto Paolo Mieli ai giornalisti che partecipavano alla discussione sulla guerra di Gaza durante la trasmissione Otto e mezzo di Lilli Gruber. Oltre a Mieli, erano presenti Lucio Caracciolo, Antonio Padellaro e Paola Caridi. L’ex direttore del Corriere della Sera ha riferito che, a cena con gli amici, pone a tutti la stessa domanda, ma nessuno ha mai fornito una risposta. Non ho autorità e nemmeno nessuna pretesa di rispondere al quesito. Mi limito a suggerire sommessamente una serie di punti che un ipotetico governante di Israele dovrebbe tener presenti affinché l’atroce prezzo di sangue pagato il 7 ottobre possa segnare se non la riapertura di un processo di pace, almeno l’inizio della discussione sull’argomento.
La prima cosa che avrei fatto sarebbe stato il chiedere scusa a tutte le famiglie dei 240 ostaggi e delle 1400 (o forse 1200) vittime che hanno pagato con la vita una politica fallimentare, crudele e spietata verso la popolazione palestinese, ma completamente inefficace nel limitare il riarmo di Hamas. Avrei poi annunciato il mio ritiro totale e definitivo dalla politica una volta che la situazione di guerra fosse terminata. In secondo luogo, avrei presentato una strategia che marcasse un cambiamento radicale rispetto all’approccio soltanto militare che ha caratterizzato la politica israeliana degli ultimi decenni. La lotta al terrorismo si deve fare principalmente con una politica di sviluppo economico a lungo termine, allargata a tutte le popolazioni della regione, con una massiccia campagna di istruzione che dia speranze ai giovani arabi e con una dura offensiva contro fanatismo ed estremismo, in campo israeliano e palestinese, la cui alleanza perversa, secondo il grande scrittore Amos Oz, ha bloccato il processo di pace.
Israele dovrebbe smettere di fare accordi sottobanco con i potentati arabi che sfruttano e opprimono le loro popolazioni. Gli interessi dei popoli e quelli delle élite al potere non coincidono quasi mai, soprattutto in Medio Oriente, dove un’enorme ricchezza finanziaria è concentrata in pochissime mani, mentre il sottosviluppo generalizzato dell’area non fa altro che accrescere la rabbia e la frustrazione delle popolazioni per essere state tagliate fuori dagli aspetti positivi della globalizzazione. Lo Stato ebraico vuole giustamente essere riconosciuto ma dovrebbe, allo stesso modo, prendere atto della realtà palestinese e dei diritti di quel popolo. La strategia per la liberazione degli ostaggi, che dovrebbe includere azioni mirate e una serrata diplomazia, va collocata in questo nuovo contesto, in modo da fornire un chiaro segnale che Israele, unico Stato democratico dell’area, può diventare una risorsa per il Medio Oriente, e non solo per gli emiri. Riporto di seguito diversi punti, alcuni immediatamente fattibili altri molto complessi e futuribili ma necessari. Il grande poeta inglese Shelley pensava che il mondo dovesse essere governato dai poeti, le persone che comprendono meglio gli eventi umani e i fenomeni della natura. Oggi il mondo avrebbe bisogno di visionari, persone in grado di vedere l’invisibile e immaginare l’inimmaginabile, visto che siamo molto vicini all’orlo del baratro.
Operazioni mirate e diplomazia
Il presidente Biden ha chiesto in più occasioni al governo di Tel Aviv di non ripetere gli errori fatti dagli Stati Uniti dopo l’11 settembre 2001. Se l’intervento in Afghanistan (risoltosi in ogni caso in un disastro) poteva essere comprensibile, dati i rapporti dei talebani con Al Qaida, la guerra scatenata contro l’Iraq nel 2003 è stata una sanguinosa prova di forza che ha inferto un grave colpo alla credibilità degli Stati Uniti come esponente di punta delle democrazie liberali. Quel conflitto, ingiustificato e al di fuori della legalità internazionale, ha contribuito a destabilizzare l’intero Medio Oriente, ha offerto alla Russia l’opportunità di insediarsi stabilmente nella regione e ha aumentato notevolmente l’influenza dell’Iran, senza risolvere nessun problema. Conscio che l’uso spropositato della violenza senza un chiaro disegno politico ha effetti nefasti, il gen. Mark Milley, Capo di Stato Maggiore della difesa statunitense fino al 30 settembre 2023 e con 44 anni di servizio alle spalle, ha dichiarato in più occasioni che le vittime civili fatte da azioni militari sproporzionate possono ritorcersi contro chi le compie perché non fanno altro che aumentare l’odio e, quindi, pregiudicare la sicurezza futura. È chiaro che è arrivato il momento di cambiare paradigma.

Moltissimi analisti concordano col gen. Milley e ritengono che le immagini delle devastazioni dei bombardamenti di Gaza avranno un impatto negativo a livello globale, soprattutto se, come sembra evidente, le operazioni delle Forze di difesa di Israele (FDI) dureranno a lungo. Settimane e settimane di foto di bambini sepolti dalle macerie, intere aree urbane rase al suolo, morte e disperazione dappertutto rischiano di diventare uno stigma per Israele e intaccare il suo status internazionale. Già oggi, il potere negoziale degli Stati Uniti, schiacciati sulla linea israeliana di brutale intransigenza, è fortemente indebolito. Molti funzionari dell’amministrazione USA riconoscono apertamente che esiste un doppio standard: condanna per i bombardamenti indiscriminati di Putin in Ucraina ma sostanziale silenzio su quelli ordinati da Netanyahu. L’inaccettabile numero di vittime civili (al momento di scrivere ha superato gli 11.000, quasi la metà minori) crea un grave imbarazzo nelle cancellerie occidentali. Il 10 novembre 2023 il presidente francese Emmanuel Macron, uno dei primi politici a portare il suo sostegno a Israele, ha concesso un’intervista in esclusiva alla britannica BBC in cui chiede senza mezzi termini il cessate il fuoco immediato. «Oggi, di fatto –ha detto il presidente francese- sono i civili a essere bombardati. Neonati, donne, anziani: bombardati e uccisi. Non c’è alcuna giustificazione e alcuna legittimità per questo. Esortiamo Israele a fermarsi».
Sicuramente i bombardamenti a tappeto riducono le perdite potenziali della fanteria meccanizzata che interviene successivamente nei combattimenti strada per strada, ma il costo in vittime civili è enorme. Netanyahu dice che la colpa è di Hamas, che usa i civili come scudi umani; le bombe che cadono hanno però incisa la stella di Davide. I terroristi di Hamas vanno stanati ed eliminati con blitz delle forze speciali, che possono colpire con maggiore precisione e ridurre al minimo le vittime collaterali, anche grazie alla sofisticata tecnologia satellitare a cui ha accesso Tel Aviv. Questa strategia operativa può aumentare le perdite israeliane ma rappresenta un modo per interrompere il ciclo di violenze e ritorsioni che scatenano nuove violenze e ritorsioni. Sembra che le forze sul terreno non capiscano la differenza tra i terroristi di Hamas o della Jihad islamica e la popolazione civile. Perché una volta bonificata un’area e distrutti i tunnel dei terroristi i soldati delle FDI non distribuiscono acqua e cibo a una popolazione che rischia di morire di fame e di sete? In questo modo i palestinesi potrebbero iniziare a guardarli in modo diverso, e mettere in discussione i dogmi di Hamas sulla necessità di eliminare tutti gli ebrei. Alla fine della Seconda guerra mondiale i soldati americani che entravano nelle città europee, messe a ferro e fuoco dai bombardamenti alleati, sorridevano e distribuivano cioccolata alla popolazione. È un concetto così complicato da imparare e mettere in pratica?
I massacri dei civili a Gaza stanno creando un clima incandescente tra le popolazioni arabe e gettando in grosse difficoltà quei governi che hanno firmato di “Accordi di Abramo”. Netanyahu è stato abilissimo a tessere una rete di alleanze per isolare l’Iran ma ha dovuto prendere atto che non è possibile far scomparire con un tratto di penna più di 5 milioni di abitanti di Gaza e Cisgiordania. Sapendo benissimo che i governi dei Paesi arabi non hanno minimamente a cuore la sorte dei palestinesi, se non a livello verbale, il più longevo politico israeliano si era illuso che avrebbe potuto tenere a bada Hamas dandogli il contentino del controllo su Gaza e favorendo i finanziamenti qatarioti. Questo mondo è finito il 7 ottobre 2023. Netanyahu non potrà più ripetere pubblicamente che far arrivare i finanziamenti ad Hamas è il modo più sicuro per impedire la nascita di uno Stato palestinese. È tutta la strategia diplomatica che va rivista, a partire dalla riapertura dei negoziati con l’Autorità nazionale palestinese, che è corrotta e inefficace ma è senz’altro preferibile agli islamisti radicali.
Una volta iniziate le discussioni sul futuro della Palestina, Tel Aviv avrebbe la possibilità di lavorare alla creazione di una articolata rete di solidarietà nei Paesi meno sviluppati, mettendo a punto una strategia per lo sviluppo che sfrutti la preziosa esperienza israeliana nel campo dell’agricoltura avanzata e dell’alta tecnologia. Tel Aviv è oggi il decimo esportatore mondiale di armi, e uno dei principali consulenti per la sicurezza e la lotta al terrorismo. Invece di concentrarsi sull’esportazione di armamenti ed esperti militari, Israele dovrebbe puntare a trasformarsi in un punto di riferimento per i Paesi del Sud del mondo (dove oggi è odiato) per l’agricoltura avanzata che fa un uso ridotto di acqua per le coltivazioni. Un ruolo cruciale in un contesto di crisi climatica che ha aumentato enormemente il fenomeno della desertificazione e la carenza idrica. Una diplomazia che punti su agronomi che aiutino i Paesi poveri a far fiorire il deserto darebbe un contributo importantissimo all’immagine di Israele, oggi noto per il suo disprezzo verso le risoluzioni dell’ONU e per la sua spietata politica militare. È vero che Niccolò Machiavelli raccomandava al principe che è preferibile essere temuto piuttosto che amato, ma siamo sicuri che questo valga anche per i Paesi poveri che da più di ottant’anni cercano, senza riuscirci, di uscire dalla miseria?
Creare un “Gabinetto di pace”
Per secoli l’organismo statale che si occupava degli eventi bellici è stato denominato Ministero della guerra. Dopo il Secondo conflitto mondiale, il nome è stato trasformato in Ministero della difesa, con qualche ipocrisia. Il Gabinetto di guerra, che sta coordinando gli attacchi a Gaza e l’ipotetica distruzione di Hamas, dovrebbe essere sostituito alla fine del conflitto da un normale governo che andrebbe però affiancato da un “Gabinetto di pace” con il compito di studiare le ipotesi per stabilizzare la situazione, grazie a fattibili progetti di sviluppo economico per Gaza e, successivamente, per la Cisgiordania. In questa struttura dovrebbe essere presente un Ministro plenipotenziario per le relazioni con i palestinesi. Il miglior candidato per questa posizione è sicuramente il maestro Daniel Barenboim, grande pianista e direttore d’orchestra, che non ha molta esperienza politica ma che avendo la cittadinanza argentina (dove è nato nel 1942), spagnola, israeliana e palestinese ha una adeguata apertura mentale. Nel 1999, insieme allo scrittore statunitense di origine palestinese Edward Said, fondò la West Eastern Divan Orchestra che aveva lo scopo di favorire il dialogo tra musicisti provenienti da Paesi e culture storicamente nemiche. L’orchestra è stata e continua a essere un successo e ha anche dimostrato come israeliani e palestinesi possano collaborare senza problemi.

Sarebbe molto importante che all’interno di questo Gabinetto ci fossero anche persone in grado di consigliare con competenza il Primo ministro sulle implicazioni umane delle scelte politiche, calate spesso nella realtà senza un’analisi adeguata sui costi da pagare. Vedo benissimo in questo ruolo la madre di un soldato israeliano caduto in servizio perché, molto meglio di un generale, ha provato letteralmente sulla sua carne quale sia il terribile prezzo per arrivare a una vittoria (transitoria, perché se non fosse così il 7 ottobre non sarebbe mai avvenuto). Secondo il mio modesto parere un’ottima candidata sarebbe Manuela Dviri Vitali Norsa, giornalista e scrittrice italo-israeliana che seguivo con piacere per i suoi articoli sul Corriere della Sera. La vita di Manuela Dviri (è il cognome del marito israeliano) si fermò il 26 febbraio 1998 quando suo figlio Yonathan, militare nelle Forze di difesa israeliane, fu ucciso in Libano durante uno scontro con gli Hezbollah. Dopo questo evento tragico, Manuela Dviri lanciò una sua campagna personale per il ritiro dell’esercito dal Libano, fece sit-in davanti alla residenza del presidente israeliano Ezer Weizman. Nel 2000 le FDI si ritirarono effettivamente dal Libano, ma per chi aveva perso un figlio la cosa non significava più molto. Nonostante due guerre e innumerevoli scontri di frontiera, il Libano rappresenta ancora una minaccia per Israele poiché ospita le potenti milizie di Hezbollah, la cui forza militare è molto superiore a quella di Hamas.
In questa struttura dovrebbe anche essere presente uno storico con il compito di studiare con molta attenzione il processo che, il 10 aprile 1998, portò alla firma dell’Accordo del venerdì santo che pose fine a trent’anni di violenze tra cattolici e protestanti nell’Irlanda del Nord. I negoziati tra le parti furono sostenuti anche a livello internazionale, soprattutto dagli Stati Uniti guidati dal Presidente Clinton, ma la chiave della riuscita dell’operazione furono gli ingenti investimenti che si riversarono sull’Irlanda e che mostrarono i vantaggi reciproci della pace. Un’altra esperienza che potrebbe tornare utile a Israele furono i complessi negoziati che portarono al potere la maggioranza nera in Sud Africa. Il principale artefice di quell’accordo storico fu Nelson Mandela, un personaggio di enorme caratura e valore. Forse, potrebbe essere una buona idea se qualche funzionario governativo con un minimo di lungimiranza iniziasse a scandagliare le carceri israeliane alla ricerca di un possibile “Mandela” palestinese.
I dati
Storicamente, la data del 7 ottobre 2023 segnerà probabilmente uno spartiacque perché ha inferto un grave colpo al mito dell’invincibilità dell’esercito israeliano ma, nel contempo, ha anche mostrato la necessità di mettere in campo una strategia diversa per arrivare a una futura coesistenza tra lo Stato di Israele e i palestinesi. Si torna timidamente a parlare di “due Stati per due popoli”. La nascita di un ipotetico Stato palestinese è però irta di enormi difficoltà storiche, militari, sociali, culturali, politiche, geografiche. Innanzitutto, i territori palestinesi sono divisi tra la Cisgiordania (quasi completamente sotto occupazione israeliana) e la Striscia di Gaza che non hanno collegamenti terrestri. Le due situazioni sono poi enormemente diverse perché Gaza è controllata da Hamas e non ha una presenza di coloni ed esercito con la stella di David. La Cisgiordania è invece un insieme frastagliato di territorio nominalmente palestinese ma popolato in modo crescente da insediamenti ebraici, circondati di altissimi muri e protetti dall’esercito di Tel Aviv. Anche la situazione economica è drammaticamente diversa, ragion per cui, in via transitoria, sarebbe più efficace ipotizzare un piano di sviluppo per Gaza e, successivamente, inserire la Cisgiordania nel disegno.
La situazione di Gaza, prima delle operazioni di terra israeliane è fotografata da un rapporto dell’UNRWA, l’Agenzia dell’ONU per gli aiuti e il lavoro dei rifugiati palestinesi. Riporto il testo: “Dopo 15 anni di blocco e ripetuti cicli di violenza l’economia ha fatto costantemente passi indietro. L’81,5% dei residenti di Gaza (di cui il 71% sono rifugiati palestinesi) vive sotto il livello di sussistenza. Il 64% ha insicurezza alimentari, la disoccupazione nel 2021 era al 47%, con un tasso di disoccupazione giovanile che toccava il 64%. Nel 2020 il Pil pro capite raggiungeva i 1.049 dollari, quattro volte meno che in Cisgiordania e in Giordania. Oggi, l’80% della popolazione dipende dall’assistenza umanitaria. Tra questi ci sono 1,1 milioni di rifugiati palestinesi che ricevono assistenza alimentare dall’UNRWA (erano 80.000 nel 2000), con un amento del 1.324%! Tra il 2007 e il 2022, 292 dei pozzi per l’acqua a Gaza, per uso domestico e agricolo, sono stati danneggiati o distrutti dalle forze israeliane. L’81% delle falde acquifere non raggiunge gli standard fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità”. I massicci bombardamenti israeliani hanno polverizzato abitazioni, vie di comunicazione, infrastrutture sanitarie e civili per cui la situazione è diventata totalmente insostenibile.
Piani di sviluppo invece di carri armati
Se guardiamo alle notizie da Gaza che i media ci rovesciano addosso ogni giorno non possiamo far altro che disperarci, ma se ricordiamo come, durante la Seconda guerra mondiale, la Germania fosse stata rasa al suolo e, in meno di vent’anni, era tornata ad essere un colosso industriale grazie alla saggia amministrazione delle truppe di occupazione alleate e alla strategia vincente del Piano Marshall, forse possiamo nutrire qualche speranza. Anche nel caso dell’Irlanda del Nord nel 1998 la chiave del successo furono gli investimenti che avrebbero prodotto ricchezza, pace e stabilità sociale. Oggi Gaza, dove metà della popolazione ha meno di 18 anni, è un inferno in terra, un cimitero a cielo aperto, la fucina dei futuri terroristi che si scaglieranno contro Israele e i suoi cittadini. Questo è un capitolo che va chiuso e bisogna spiegare ai politici di Tel Aviv che l’unico investimento serio per la sicurezza nazionale consiste in progetti di sviluppo industriale, infrastrutturale e agricolo per l’area. Dopo aver abbandonato la Striscia, Israele ha esercitato un controllo ferreo sui confini terrestri, le merci, i rifornimenti di gas, elettricità e acqua. Questo ha costretto la popolazione a ricorrere ai tunnel per contrabbandare il necessario per vivere e, paradossalmente, ciò ha favorito Hamas che ha visto aumentare il proprio consenso e usato i tunnel per rafforzare la sua strategia terroristica.
In realtà, l’eliminazione del blocco e un progetto di sviluppo per Gaza per azzerare il rischio terroristico era stato messo a punto nel settembre del 2021 dal ministro degli Esteri Yair Lapid, col tacito consenso del primo Ministro Naftali Bennet. Il piano includeva progetti infrastrutturali e creazioni di posti di lavoro. Dopo aver riconosciuto che la campagna di violenza verso Israele era spiegata dal fatto che i palestinesi «vivessero in condizioni di povertà, scarsità, violenza e alta disoccupazione senza speranze per il futuro», Lapid aveva proposto un piano per cambiare la situazione. In un discorso all’Università Reichman a Herzliya, il ministro degli Esteri aveva dichiarato: «Ripareremo il sistema elettrico, collegheremo il gas, verrà costruito un impianto di desalinizzazione dell’acqua, miglioreremo il sistema sanitario e ricostruiremo le infrastrutture e il sistema dei trasporti». In cambio, Lapid chiedeva «un impegno di Hamas per una politica di calma a lungo termine». Se la prima parte dell’accordo avesse funzionato, si sarebbe passati alla realizzazione di un’isola artificiale al largo della costa per costruire un porto che aprisse Gaza al commercio internazionale. Lapid si impegnava anche a realizzare una “linea di trasporto” che avrebbe collegato Gaza alla Cisgiordania. Il piano era stato presentato ai “partner nel mondo arabo”, come pure a Stati Uniti, Russia e Unione Europea. Ma poi il governo era caduto e nelle elezioni del novembre 2022 era tornato al potere l’immarcescibile Benjamin Netanyahu e si era tornati alla politica di sempre.
L’approccio di Yair Lapid è quello giusto. Nel corso degli anni sono stati realizzati innumerevoli progetti, più o meno fattibili, ma è sempre mancata la volontà politica e la lungimiranza per ipotizzare un futuro diverso. Poiché, comunque vadano le cose, la parabola di Netanyahu è agli sgoccioli, e anche i suoi alleati estremisti sono indeboliti a livello internazionale, si potrebbe aprire una nuova finestra di opportunità. Un problema enorme nell’elaborare una strategia per lo sviluppo di Gaza è individuare lo strumento adeguato che lo possa gestire. Negli ultimi decenni né il Fondo Monetario Internazionale né la Banca Mondiale hanno dato buona prova di sé e, d’altronde, non godono di grande credibilità nell’intero Medio Oriente. Forse, la struttura più adatta sarebbe una ipotetica Banca per lo Sviluppo Regionale (BSR) che si occupasse di Gaza ma avesse anche il mandato per finanziare progetti di sviluppo per il Libano (una bomba a orologeria che potrebbe esplodere in qualsiasi momento), la Siria, la Giordania, l’Iraq. Ma la priorità dovrebbe essere Gaza, la creazione di posti di lavoro, l’identificazione di un percorso per uscire da una crisi drammatica che produce disperazione e, quindi, rabbia e nichilismo che ingrossano le file degli estremisti islamici. Se i giovani della Striscia iniziassero a vedere una prospettiva per il futuro si potrebbe interrompere la spirale di violenza che va avanti da decenni e che l’attuale invasione israeliana non farà altro che rinfocolare. Il modello dovrebbe essere sempre l’ultracitato Piano Marshall che, a tutt’oggi, rimane un ineguagliato successo di dimensioni storiche.
Gaza come nuova Singapore
I fondi alla BSR dovrebbero arrivare in primis da una conferenza mondiale dei donatori, simile a quella che si è appena conclusa a Parigi, dai Paesi arabi, che non mancano certo di liquidità, dall’Unione Europea, da grandi magnati privati come, ad esempio, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, dalla potente lobby ebraica degli Stati Uniti che ha tutto l’interesse a stabilizzare una situazione che, finora ha portato morte e distruzione. Gaza ha una superficie di soli 365 chilometri quadrati e una popolazione di circa 2,3 milioni (di cui la metà sono giovani) e quindi un’ampia disponibilità di manodopera. La brutalità dei bombardamenti israeliani ha probabilmente risolto il problema di cosa si dovrebbe ricostruire. La risposta è: tutto. Dopo le immani distruzioni della guerra, a partire dal 1945 l’Europa fu ricostruita in circa dieci anni. Il processo si potrebbe rifare in un tempo molto più breve per un’area molto limitata e con una popolazione enormemente minore. Ma perché ci dovrebbe essere un interesse internazionale per risolvere un problema così localizzato?
La non soluzione del problema palestinese ha causato crisi a ripetizione, tensioni sui prezzi energetici, ha prodotto instabilità nell’area e stimolato la nascita di un terrorismo che, travalicando il Medio Oriente, ha insanguinato il mondo. Tutti trarrebbero vantaggio dal fatto che Gaza diventasse un fiore all’occhiello nel mondo arabo, perché questo sgonfierebbe le rivendicazioni, giustificate o meno, rivolte verso i Paesi occidentali. Fattore non marginale, una Gaza stabilizzata contribuirebbe anche a isolare la teocrazia iraniana che esporta droni, armamenti e milizie fanatiche ma non sa ne può dare nulla a chi desidera pace e prosperità. Lo sviluppo di infrastrutture portuali nella Striscia aprirebbe la possibilità di inserirla nel progetto di un corridoio economico che colleghi India, Medio Oriente ed Europa, come è stato annunciato all’incontro del G7 tenutosi lo scorso settembre a Nuova Delhi. Tra i firmatari ci sono Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, India, Italia e Unione Europea, tutti Paesi che avrebbero un grande interesse a entrare nella BSR, in special modo l’Arabia Saudita, che vedrebbe rafforzato il suo ruolo nel mondo sunnita, a scapito del concorrente turco, attivissimo a livello militare ma con pochi successi per quanto riguarda lo sviluppo economico nel Sud del mondo.
Un’attenzione particolare dovrebbe poi essere rivolta alla rinegoziazione degli accordi sui giacimenti di gas e petrolio al largo di Gaza. Non se discute molto, ma al largo della costa israeliana e di Gaza ci sono ingenti risorse energetiche estratte soltanto da Tel Aviv che ha sempre impedito ai palestinesi di accedervi. Nel 1999 l’Autorità Palestinese concesse una licenza per la ricerca di idrocarburi al British Gas Group, che l’anno successivo scoprì un grosso giacimento al largo delle coste di Gaza, noto come Gaza Marine. Se sfruttato adeguatamente, quel gas potrebbe coprire l’intero fabbisogno palestinese e consentirebbe anche di effettuare esportazioni. Tuttavia, l’estrazione non è mai iniziata perché, in seguito all’ascesa al potere di Hamas nel 2007, Israele ha dichiarato un blocco navale intorno alla Striscia, impedendo così anche l’accesso al giacimento. Se cambiasse il paradigma politico sarebbe possibile rimettere in moto l’economia e aprire una nuova fase per intaccare finalmente il sottosviluppo dell’area.

A prima vista, un paragone con Singapore, uno dei Paesi con il più alto tasso di reddito pro capite al mondo, sembra una follia ma se osserviamo con attenzione, vediamo che nella storia ci sono stati moltissimi casi di nazioni poverissime (un caso eclatante è stato quello della Corea del Sud) che hanno saputo uscire dalla loro situazione di miseria. Innanzitutto, le dimensioni sono comparabili: 365 chilometri quadrati per Gaza e 733 per Singapore. Nel 1960, però, Singapore, che è costituito da 63 isole, si estendeva soltanto per 581,5 chilometri quadrati. L’aumento del territorio è dovuto a massicci lavori di bonifica e trasporto di terra e si stima che, entro il 2030, la superficie possa crescere di altri 100 chilometri quadrati. Certamente lo sviluppo economico e finanziario di Singapore fu favorito dalla sua vantaggiosa posizione geografica, ma se guardiamo una cartina, ci rendiamo subito conto che Gaza dista meno di 400 chilometri da Cipro che fa parte dell’Unione Europea. Con le opportune infrastrutture, la Striscia potrebbe essere inserita vantaggiosamente all’interno dei commerci che collegano le economie orientali e l’Europa.
La creazione di isole artificiali, prevista anche dal piano di Yair Lapid, è fondamentale perché il consumo di suolo per le infrastrutture industriali va assolutamente evitato, vista la già altissima densità di popolazione. Il piano di generale della BSR dovrebbe essere la creazione di un’agricoltura avanzata, associata allo sviluppo industriale. Forse, gli artigiani che producono razzi fatti in casa, che vengono poi lanciati contro Israele, sarebbero altrettanto bravi nel costruire trattori e macchinari agricoli, o sistemi di irrigazione per le serre, o impianti fotovoltaici. Pura follia, libro dei sogni irrealizzabili, progetti utopistici? Guardate le foto degli israeliani i cui parenti sono stati rapiti dai terroristi o quella dei padri palestinesi che stringono il cadavere impolverato e coperto di sangue di un figlio e pensate che, se ci fosse la volontà politica, potrebbero avere la possibilità di un futuro diverso. Non ne varrebbe la pena?
L’immagine di copertina riproduce una coltivazione idroponica nel padiglione belga dell’Expo 2015 (Foto di Sergio D’Afflitto Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto e provvederemo alla sua cancellazione dal sito